
Dato un insieme, la risultante di un insieme varia al variare di un fattore dell'insieme.
Dato un insieme di risultanti di insiemi, la risultante dell'insieme varia al variare di ogni risultante di ogni insieme contenuto.
Giugno 2025: la filosofia metafisica della Religione Pagana.
14 giugno 2025
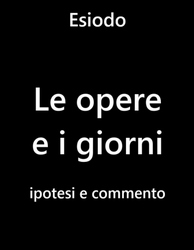
Esiodo apre il testo su "Le opere e i giorni" trattando della contesa. Che abbia preso spunto dalla contesa col fratello per l'eredità, che si concluse davanti ad un tribunale che favorì il fratello, è molto probabile.
Sta di fatto che leggendo il testo di Esiodo, sembra di leggere il "Trattato sulle contraddizioni" di Mao Tse Tung,
Scrive Esiodo:
Sulla terra non v'è un sol genere di Contesa, bensì due ve ne sono; e mentre l'una è lodata dal saggio, l'altra è riprovevole: hanno infatti indole diversa. L'una, la trista, favorisce la guerra luttuosa e la discordia: nessun mortale l'ama di sicuro, tuttavia, per destino, per volere degli Immortali, si coltiva questa gravosa Contesa. La Notte tenebrosa, per prima, generò l'altra, e il Cronide dall'alto trono, abitatore dell'etere, la pose nelle radici della terra: molto migliore è questa, per gli uomini: essa, infatti, esorta il neghittoso al lavoro. Perché l'ozioso, volgendo lo sguardo a uno più ricco, si affretta a seminare, a coltivare e a ben governare la casa; il vicino emula il vicino che alla ricchezza attende. Buona Contesa è questa per i mortali: il vasaio gareggia col vasaio, l'artigiano con l'artigiano, il povero invidia il povero, il cantore il cantore.
Tratto da Esiodo, Le opere e i giorni, Editore BUR, 1958, pag. 13-14
Mao Tse Tung diceva che le contraddizioni sono fra noi, fra noi e il nemico e fra noi e la natura.
Le contraddizioni vengono distinte dai mezzi che si usano per risolverle: quelle fra noi si risolvono attraverso la discussione e la mediazione; quelle fra noi e il nemico con la diplomazia e la guerra; quelle fra noi e la natura si risolvono mediante il lavoro.
Usare il termine di contraddizione o usare il termine di contesa non cambia la natura dell'oggetto a cui ci riferiamo.
Della contraddizione che si risolve attraverso la guerra, Esiodo dice:
"L'una, la trista, favorisce la guerra luttuosa e la discordia: nessun mortale l'ama di sicuro, tuttavia, per destino, per volere degli Immortali, si coltiva questa gravosa Contesa."
A nessuno piace dover affrontare contraddizioni che si risolvono mediante la guerra perché portano distruzione e lutti; favoriscono poche persone; distruggono le società degli uomini.
Della contraddizione fra noi e la natura che si risolve mediante il lavoro, Esiodo dice:
"La Notte tenebrosa, per prima, generò l'altra, e il Cronide dall'alto trono, abitatore dell'etere, la pose nelle radici della terra: molto migliore è questa, per gli uomini: essa, infatti, esorta il neghittoso al lavoro. Perché l'ozioso, volgendo lo sguardo a uno più ricco, si affretta a seminare, a coltivare e a ben governare la casa; il vicino emula il vicino che alla ricchezza attende. Buona Contesa è questa per i mortali: il vasaio gareggia col vasaio, l'artigiano con l'artigiano, il povero invidia il povero, il cantore il cantore."
Della contraddizione fra noi, che si risolve mediante il dibattito, Esiodo la dimostra dibattendo in tribunale col fratello al quale Esiodo dice:
0 Perse, poniti bene in mente questo, e la Contesa che gioisce del male non ti distolga l'animo dal lavoro per farti stare a spiare i tribunali e a prestar orecchio alle liti. Poco tempo, infatti, resta per liti o per discordie a chi non ha in casa mezzi più che sufficienti di vita, la spiga di Demetra e i frutti di stagione che la terra porta. Se tu sei sazio, allora favorisci pure liti e discordie contro i beni degli altri; ma non potrai agire così una seconda volta: definiamo qui allora la lite secondo quelle rette sentenze che, provenendo da Zeus, sono le migliori. Già infatti dividemmo l'eredità, e tu, derubandomi, molte cose arraffasti, corrompendo i giudici, divoratori di doni, i quali consentono di emettere tali sentenze. Stolti! non sanno come la metà valga più del tutto né quale grande vantaggio vi sia nella malva e nell'asfodelo
Tratto da Esiodo, Le opere e i giorni, Editore BUR, 1958, pag. 14
La contraddizione fra noi si risolve col dibattito, ma quando il dibattito si fa acceso, nella società in cui viviamo, a parte la corruzione morale dei magistrati, dovrebbero essere i magistrati a condurre il dibattito secondo condizioni di giustizia ed equità.
Le Opere e i Giorni, si aprono con la "necessità di agire" dove la necessità di agire, modifica il presente in cui le persone agiscono.
Questo testo di Esiodo viene collocato dalla maggior parte degli studiosi nell'VIII secolo a.c. Secondo il Prof. Scarpa, curatore del testo che io analizzo, colloca Esiodo fra il 675 e il 700 a.c., posteriore ad Omero. Almeno 100 anni prima di Pitagora e di Talete.
Che piaccia o meno, la teoria delle contraddizioni o delle contese, viene intuita come movimento del presente ben prima che una filosofia fissasse un qualche "principio di verità" con l'Uno di Pitagora o il Tutto di Parmenide.
La teoria delle contese, è stata presentata anche nella Teogonia dove Contesa, figlia di Nera notte, ha molti figli simili ai "mali" che escono dal vaso di Pandora.
Il vaso di Pandora trasferisce i figli di Contesa, nella Teogonia sono: "CONTESA generò PENA DOLENTE, OBLIO e FAME, e DOLORI, che fanno piangere, LOTTE e BATTAGLIE e DELITTI e OMICIDI, DISCORDIA e INGANNI e DISCORSI e AMBIGUI DISCORSI, ANARCHIA e SCIAGURA che vanno congiunte fra loro e GIURAMENTO, che agli uomini della terra grande sciagura reca quando qualcuno di loro, volendo, spergiura."
Un mondo in cui gli Esseri Umani devono affrontare ciò che considerano "pene dolenti", "oblio", "fame", "dolori che fanno piangere", "lotte", "battaglie", "delitti", "omicidi", "discordia", "inganni", "discorsi", "ambigui discorsi", "giuramenti e spergiuri", è un mondo che richiede volontà, impegno e attenzione. Richiede tutte quelle arti di cui Atena è manifestazione.
Da questo si può comprendere l'odio di Pitagora e di Platone per i poeti che indicavano la vita come contraddizione capace di coinvolgere le persone, a differenza dei "filosofi padroni di uomini" che invocavano la pace di un assoluto, di un creatore, al fine di conservare il loro potere e il loro dominio sugli uomini.
Con la teoria della contesa, inserita in ogni discorso filosofico, si inserisce il concetto di cambiamento, di modificazione del presente.
Già Omero, sempre che lo si voglia collocare prima di Esiodo, con i suoi poemi ha introdotto nella filosofia il concetto di guerra, con l'Iliade, (contesa furiosa), e il concetto di "viaggio" come trasformazione, cammino, Odissea (cammino come rappresentazione della vita). Desumere questi concetti dalle opere di Omero non era agevole per la maggior parte dei lettori mentre, per i filosofi che auspicavano un mondo statico, obbediente e sottomesso, come Pitagora, Parmenide, Socrate, Platone, Aristotele, i poeti rappresentavano i nemici, coloro che indicavano agli uomini la possibilità di agire e di ottenere dei risultati proprio perché avevano deciso di agire. Per persone come Pitagora, Parmenide, Socrate, Platone e Aristotele, che pretendono di imporre leggi e comportamenti come se fossero tanti "Dio creatore e padroni cristiani", osservare degli uomini che usando la loro volontà affrontano le contese della loro esistenza affrontando le avversità e trovando delle possibili soluzioni anziché attendere la provvidenza dei loro padroni, era qualche cosa di terribile, da allontanare con la massima determinazione.
La filosofia, nei suoi inizi, inizia a subire gli attacchi violenti da Pitagora.
Scrive di Pitagora Diogene Laerzio:
Ieronimo dice che Pitagora sarebbe disceso nell'Ade e avrebbe visto l'anima di Esiodo legata a una colonna di bronzo e urlante e quella di Omero appesa a un albero e circondata di serpenti, come punizione per ciò che entrambi avevano detto riguardo gli dei;
Diogene Laerzio, pag. 216
Con Pitagora la vita non è contesa, è accettazione passiva delle conseguenze della reincarnazione come trasmigrazione delle anime.
La guerra contro il Daimon dell'uomo, era iniziata. Esiodo parla dell'uomo che si costruisce, che modifica il proprio presente, costruendo il proprio Daimon, Pitagora eleva l'Uno a padrone degli uomini e l'anima, distinta dall'individuo come controllo dell'individuo che viene premiato o punito con la reincarnazione.
14 giugno 2025

Le idee sono come le parole. Vengono costruite ed usate in un contesto abbastanza preciso e in quel contesto assumono il loro significato. Un significato che non può essere esteso a contesti culturali diversi a mano che non si voglia piegare i contesti culturali diversi a quelle idee perché servono a qualcuno per i suoi fini.
Come in questo caso dove un'idea della filosofia greca, con ben precisi scopi di controllo sociale, viene, da Erodoto, attribuita all'Egitto facendo credere che sia più antica e più universale di quello che, in realtà, è.
Quando Erodoto afferma che:
Gli Egizi per primi affermarono che l'anima dell'uomo è immortale e che al perire del corpo emigra in un altro degli esseri che nascon via via. E quando li abbia passati tutti, terrestri marini e volatili, di nuovo rinasce nel corpo d'un uomo; e questo giro per essa si compie in tremila anni. Ci furono dei Greci che seguirono questa dottrina affermandola come loro propria, alcuni in tempi passati, altri di recente; so i loro nomi, ma non sto a scriverli.
Maria Timpanaro Cardini, curatrice de "Pitagorici antichi" commenta la questione affermando:
Bisogna qui distinguere la dottrina sull'immortalità dell'anima che risale all'Egitto in tempi remotissimi, da quella delle sue trasmigrazioni, di cui è stato detto non esservi traccia in alcun documento nazionale egizio (Zeller Phil. Gr., I p. 62 ; ma cfr. Mondolfo in Zell.-Mond., I p. 133 n. 2); ed è vero, nel senso che non c'è traccia di una dottrina eticocatartica dell'anima attraverso successive palingenesi; c'è solo la dottrina del "defunto giustificato", cioè divenuto simile a Osiride, che come tale può trasformarsi come vuole, rivestir forme varie umane e animali, e anche tornar sulla terra.
(Entrambe le citazioni) Da Pitagorici Antichi, testimonianze e frammenti a cura di Maria Timpanaro Cardini, Editore Bompiani, 2010, pag, 21
Anche il concetto di "anima" degli egiziani, non è il concetto di anima di Pitagora e Platone. E' più vicino al concetto di Daimon come la parte "immortale" dell'individuo che è propria dell'individuo.
Gli Egiziani non credevano nella reincarnazione. Lo dissi un sacco di volte a coloro che pensano di estendere l'idea Pitagorica e Platonica all'antico Egitto. Ma loro ne hanno bisogno perché, se l'idea non è così antica, si sentono smarriti.

Imparare come si tratta con gli USA
Tutti i testi del mese di giugno 2025 in un'unica pagina
Indice pagine mensili di cronache Pagane
Torna agli argomenti del sito Religione Pagana
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
Membro fondatore
della Federazione Pagana
Piaz.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
Tel. 3277862784
e-mail: claudiosimeoni@libero.it
Iside con bambino - Museo di Napoli prestata a Torino!
Questo sito non usa cookie. Questo sito non traccia i visitatori. Questo sito non chiede dati personali. Questo sito non tratta denaro.