
Rimpiangiamo: per non aver pensato quello che avremmo dovuto pensare quando potevamo pensarlo;
per non aver detto quello che avremmo potuto dire quando potevamo dirlo;
per non aver fatto quello che avremmo dovuto fare quando potevamo farlo
Luglio 2025: la filosofia metafisica della Religione Pagana.
19 luglio 2025
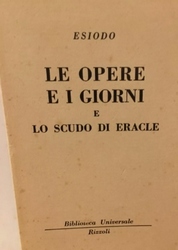
In questi consigli, che sanno di morale e di etica, Esiodo individua "l'altro" nel vicino e nel parente. Esiodo è un po' come Esopo, parla all'uomo per gli interessi e i problemi che coinvolgono l'uomo. Non è interessato al potere o al dominio giuridico delle città. Esiodo non è uno statista, è un uomo che abita il mondo e riflette su quale sia il modo migliore per abitarlo.
Esiodo non si preoccupa di definire la "natura degli Dèi". Per Esiodo gli Dèi esistono e gli uomini devono avere un certo rispetto e una certa attenzione. Gli Dèi in Esiodo rappresentano il "mondo altro", il mondo sul quale non si può discutere, ma solo affermare. Non c'è deferenza o sottomissione nelle parole di Esiodo in relazione agli Dèi. Fare sacrifici agli Dèi permette di organizzare i banchetti e ai banchetti si invitano le persone.
Scrive Esiodo in relazione agli Dèi:
Ma tu, o stolto, distogli la tua mente da queste cose! Santificato e purificato, sacrifica agli Dei immortali secondo le tue possibilità; offri loro vittime scelte, propiziali con libagioni e con sacrifici, sia quando vai a dormire, sia quando spunta la luce, così che gli Dei abbiano ben disposti verso di te l'animo e il cuore: tu allora sarai in grado di comperare un altro podere, non altri il tuo.
Esiodo, Le opere e i giorni, Editore BUR, 1958, pag. 25/27
Gli Dèi, dice Esiodo, in questo modo ti camminano a fianco favorendoti quando intraprendi un'impresa e permettendoti di raggiungere i risultati che ti sei prefissato.
Se costruisci un equilibrio fra te e gli Dèi, potrai raggiungere i tuoi obbiettivi e forse, comperare un altro podere anziché cadere in rovina e permettere ad altri di impossessarsi del tuo podere.
Il podere, in Esiodo, sta per il mezzo di sostentamento e di arricchimento della persona. Lavorare, curare, il podere garantisce il benessere. Essere costretti a vendere il podere significa cadere in miseria, rinunciare alla costruzione del proprio benessere.
Una volta presentata da Esiodo la convenienza nell'onorare gli Dèi, Esiodo descrive alcune regole comportamentali attraverso le quali onorare gli uomini.
I sacrifici erano il rituale attraverso il quale preparare i banchetti con le relative libagioni. Questi banchetti erano anche un rituale collettivo in cui si costruivano le relazioni fra gli uomini. Uomini che Esiodo identifica come "i vicini", "gli amici" e i "parenti".
Scrive Esiodo:
Invita al banchetto l'amico e lascia il nemico, e sopra tutto invita colui che ti abita accanto: se a te, infatti, accadrà qualcosa, i vicini correranno discinti, vestiti i passanti! Il cattivo vicino è una rovina, il buono un grande aiuto; ebbe in sorte un tesoro chi ebbe in sorte un buon vicino: neanche un bue morirebbe, se il vicino non fosse cattivo! Fatti ben misurare dal vicino ciò che ti occorre, e restituiscigli la stessa misura e anche di più, se lo puoi, acciocché, avendone in futuro ancora bisogno, tu lo ritrovi pronto. Non fare cattivi guadagni: essi sono simili a sventure.
Esiodo, Le opere e i giorni, Editore BUR, 1958, pag. 25/27
Esiodo delinea caratteri di correttezza nei confronti dell'altro, del vicino. Caratteri che implicano un comportamento soggettivo limpido e privo di doppi fini o di scopi diversi da quanto il comportamento indica.
Se oggi come oggi si possono trovare abbastanza normali questo tipo di relazioni, è necessario ricordare come la bibbia di ebrei e i cristiani manifesta azioni apparentemente solidali, ma con scopi di rapina nei confronti di coloro dei quali hanno recitato l'atto di solidarietà.
Tu hai interesse, dice Esiodo, ad avere un buon comportamento con il vicino. Hai interesse ad essere generoso, per quel che puoi, nei suoi confronti perché la solidarietà è una questione di reciprocità. La solidarietà si paga con la solidarietà, non con la gratitudine.
Per i cristiani, l'atto di solidarietà deve essere ripagato da colui che lo riceve con la sottomissione al benefattore che, col beneficio, si appropria del disgraziato che era nel bisogno.
Si tratta dell'insegnamento evangelico relativo al "Buon Samaritano" la cui morale viene conclusa con:
Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?". Quegli rispose: "Chi ha avuto compassione di lui". Gesù gli disse: "Va' e anche tu fa' lo stesso".
Vangelo di Luca, 10, 36-37
L'azione non è un'azione di solidarietà, ma è un'azione finalizzata ad ottenere una sottomissione, una riconoscenza, che altrimenti non ci sarebbe stata. La solidarietà è propria del genere umano, la riscossione del debito di gratitudine è un'imposizione educazionale cristiana per monetizzare, in qualche forma, la solidarietà.
L'azione per mettere in difficoltà l'altro, fingendo poi di aiutarlo come premessa per la sua distruzione, è propria dell'ideologia ebrea e cristiana. A volte si è in difficoltà e i cristiani ne approfittano per vendere la propria azione e riscuotere riconoscenza. Altre volte, più spesso, creano le situazioni di sofferenza e difficoltà per costringere gli uomini a sottomettersi sia per la violenza che per la riconoscenza.
E' la strategia dei proverbi della bibbia, ripresi da Paolo di Tarso il criminale impotente che deve rendere impotente l'umanità.
Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, se ha sete, dagli acqua da bere; perché così ammasserai carboni ardenti sul suo capo e il Signore ti ricompenserà.
Bibbia, Proverbi 25, 21-22
Riprende il concetto Paolo di Tarso:
Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male.
Paolo di Tarso, Romani 12, 20-21
Accumulare carboni ardenti sulla testa del tuo nemico, fingendo di sfamarlo o di dargli da bere, è proprio di ebrei e cristiani.
Più colui che si considera nemico è in difficoltà, più si accumulano carboni ardenti sulla sua test in modo che sia ancora più in difficoltà.
Per Esiodo, il cristiano è un cattivo vicino pronto ad accumulare carboni ardenti sulla testa del vicino in difficoltà.
Dice Esiodo:
Il cattivo vicino è una rovina, il buono un grande aiuto; ebbe in sorte un tesoro chi ebbe in sorte un buon vicino
Essere dei buoni vicini significa il rispetto per le diversità dei vicini quando questi non interferiscono con la propria vita. Rispetto significa essenzialmente "non interferire con la vita del vicino" quando questa non interferisce con la propria. In termini volgari è, essenzialmente, "farsi gli affari propri" mettendo però attenzione alle necessità dei vicini.
Scrive Esiodo:
Ama chi t'ama, e va' incontro a colui che ti viene incontro; da' a chi ti dà e non dare a chi non ti dà. Uno dà a chi dà: a chi nulla mai diede, nessuno ha mai dato. Il dare è bene, è un male, invece, la rapina datrice di morte. L'uomo dona di cuore, anche se si tratta di un grande dono, gioisce e si rallegra nell'animo proprio; chi invece, fidando nella sua sfrontatezza, si serve da solo, anche per poca cosa, sente gelo nel cuore.
Esiodo, Le opere e i giorni, Editore BUR, 1958, pag. 25/27
La reciprocità è il principio chiave che regola le norme etiche e morali in Esiodo.
Rispondi con amore a chi ti offre amore. Se qualcuno ti viene in aiuto, aiutalo a tua volta. Paga con la stessa moneta: amore con amore; aiuto con aiuto, amicizia con amicizia, attenzione con attenzione.
Esiodo condanna la rapina. Il concetto di rapina di Esiodo è molto più profondo di come gli interpreti cristiani hanno voluto farlo apparire.
Dice Esiodo:
chi invece, fidando nella sua sfrontatezza, si serve da solo, anche per poca cosa, sente gelo nel cuore.
La frase di Esiodo non si inserisce in un ambiente gerarchico, ma si inserisce in un ambiente paritario dove la gerarchia della proprietà non è stata ancora socialmente accettata, ammessa o codificata.
Il termine che usiamo oggi "rubare" parte dal presupposto che esista una proprietà privata sociale, legittima e giuridicamente determinata. Il padrone possiede e il ladro è colui che sottrae qualche cosa al proprietario.
Questa situazione non c'è in Esiodo. Gli Dèi non hanno decretato l'esistenza di una "proprietà privata" (come fa il Dio dei cristiani la cui caratteristica è quella di possedere e, da qui la definizione di "Dio padrone") legittimando in qualche modo il possesso come diritto.
In Esiodo, non esistendo la "proprietà privata" esiste solo la "proprietà d'uso", in altre parole, io possiedo quanto uso per vivere.
In questo caso, tu non rubi un milione di euro da una banca che possiede miliardi di euro. Tu ti appropri di qualche cosa che mi è necessario per vivere, ti appropri della mia vita di cui quell'oggetto è parte.
Per questo motivo, Esiodo dice:
"è un male, invece, la rapina datrice di morte"
E' importante definire il contesto in cui avvengono le affermazioni perché, in un contesto cristiano, in cui Dio e i suoi emissari hanno rapinato gli uomini di ogni cosa definendo per sé il diritto di proprietà privata, gli uomini, rapinandoli, non fanno altro che riprendersi il mal tolto. Quando si definisce giuridicamente il diritto alla proprietà privata, si definisce il diritto acquisito di un rapinatore di aver rapinato gli uomini.
Per quante compensazioni possono essere giuridicamente definite, il sistema giuridico di una società non fa altro che legittimare una rapina che è avvenuta e i meccanismi per perpetuare quella rapina salvaguardando il rapinatore.
Esiodo, nei pochi principi etico-morali, riflette sul futuro:
Se tu aggiungi poco al poco, ma questo farai di frequente, presto il poco diverrà molto. Chi aggiunge a quello che ha scaccerà la fame dall'arido volto; quello che si ha in casa non dà pensieri. Il meglio è ciò che si ha in casa, quello che ne è rimasto fuori corre pericolo. è buona cosa prendere da ciò che hai, ed è penoso per l'animo aver bisogno di ciò che non si ha; sul che ti esorto a ripensare. Sàziati dell'orcio quando esso è all'inizio o sta per finire, risparmialo, invece, se a metà: è inutile risparmiare alla fine. Il compenso all'amico sia fedele e sicuro.
Esiodo, Le opere e i giorni, Editore BUR, 1958, pag. 25/27
Se tu hai qualcosa, magari molto poco, ma a quel poco aggiungi qualche cosa, giorno dopo giorno, quando puoi, come puoi, senza prendere dal poco che conservi, quel poco diventerà molto.
E' da ricordare che questo principio è l'opposto del principio cristiano sulla provvidenza divina. E' l'uomo che, aggiungendo un poco al poco che possiede, costruisce un molto e non attende la provvidenza che gli risolva i problemi o che gli riempia le tasche.
"Scacciare la fame dall'arido volto" è l'impresa epica dell'uomo che aggiunge a quello che ha e non rimane scoperto e impotente davanti agli eventi, anche quando questi possono essere tragici.
"Quello che si ha in casa, non dà pensieri" perché è la propria ricchezza che fornisce aiuto e supporto nelle condizioni della propria vita.
"è penoso per l'animo aver bisogno di ciò che non si ha"
Per cui, provvedi prima in modo di avere quando hai la necessità di avere perché quando i problemi si presentano, è inutile che supplichi il Dio dei cristiani affinché ti soccorra nell'indigenza. Il Dio dei cristiani si ciba della disperazione degli uomini vendendo loro speranza come fosse una dose di eroina.
Più complesso è interpretare l'esempio dell'orcio. La domanda che Esiodo non pone è: quando avrai il prossimo orcio di cibo o vino da cui attingere?
Se sei all'inizio dell'orcio, ne hai in abbondanza; se prevedi di avere un altro orcio e sei alla fine dell'orcio, puoi mangiare o bere in abbondanza; ma se si è a metà orcio e non sai quando arriva il prossimo orcio, quello è il momento di risparmiare per avere più tempo per aspettare il prossimo orcio. Si tratta di un principio di prudenza: azione e conseguenza per proteggere la propria vita.
Se hai chiesto qualcosa all'amico e hai promesso in cambio un compenso, mantieni la tua parola nella quantità del compenso e nei tempi in cui lo consegni. In sostanza, comportati con onore.
Ed Esiodo chiude i suoi concetti etico-morali con i parenti e con la donna.
Scrive Esiodo:
Anche col fratello, sia pure per scherzo, chiama un testimonio; il fidarsi, infatti, e il non fidarsi rovinarono l'uomo. Né una donna poco per bene t'inganni il cuore chiacchierando con grazia mentre fruga per la tua casa. Chi si fida della donna si fida di un ladro. è bene avere un sol figlio nella casa paterna, così aumenterà il patrimonio; e che tu possa morir vecchio lasciando un figlio. Facilmente Zeus, se vuole, può dare agio infinito a più figli; maggiore è il lavoro di molti, maggiore il profitto. E se il tuo cuore ha nel petto desiderio di agi, devi agire così, e aggiungere lavoro al lavoro.
Esiodo, Le opere e i giorni, Editore BUR, 1958, pag. 25/27
Dopo l'esperienza che Esiodo ha avuto col fratello Perse, indica alle persone che quando fanno patti, anche con un fratello, chiamino un testimone perché sia il fidarsi che il non fidarsi rovinano l'uomo.
L'avessi interiorizzato prima io questo principio, forse i miei genitori e i miei fratelli non mi avrebbero derubato delle mie risorse e saccheggiato la mia vita. Mi sono fidato e sono stato fortemente danneggiato. Per loro gli estranei erano più importanti di colui a cui avevano derubato vita e risorse.
Si dice che Esiodo fosse misogino e nutrisse rancori con le donne. Probabilmente è vero, ma, una società in cui gli uomini considerano la donna un "essere inferiore", producono certamente donne capaci di sopravvivere. Donne che devono essere temute da uomini che si sentono superiori.
Probabilmente, ai tempi di Esiodo (e anche dopo fino a pochi decenni fa, ma anche ora per molte donne) l'uso di sé stesse per accaparrarsi dei vantaggi equivale alle sopraffazioni di forza fisica che gli uomini usano per accaparrarsi dei vantaggi l'uno con l'altro e sulle donne. Se non consideri la donna, o colui di un'altra razza, altro da te e come te, l'altro non considera te come sé e diventi una preda come tu hai voluto trasformare lui in una preda.
Dunque, se hai voluto trasformare la donna in una preda, aspettati di essere da lei predato.
Da qui l'affermazione di Esiodo:
"Chi si fida della donna si fida di un ladro."
A parte il discorso sui figli in relazione al patrimonio, per un'eredità che non vada divisa, Esiodo conclude il suo discorso di etica-morale affermando:
"E se il tuo cuore ha nel petto desiderio di agi, devi agire così, e aggiungere lavoro al lavoro."
Il lavoro che costruisce la ricchezza. Un concetto presente in Esiodo e assente nella bibbia ebrea e cristiana.
Anche questo principio si oppone ai principi dei Vangeli cristiani:
Disse poi una parabola: "La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio".
Vangelo di Luca 12, 16-21
L'uomo ha deciso di costruire magazzini più grandi dove mettere il raccolto che ha ottenuto col suo lavoro; consapevole di aver accumulato beni dice a sé stesso che è ora di riposarsi, di andare in pensione.
Vista la decisione dell'uomo, il Dio dei cristiani decide di ucciderlo.
Il Dio dei cristiani deride il lavoro dell'uomo. Lui è il padrone e solo lui può decidere quando gli uomini possono guadagnare e vivere perché lui afferma di dare agli uomini sia il guadagno che costoro si sono sudati che la loro stessa vita.
Le parole del Gesù dei cristiani sono le parole di un criminale che dice agli uomini: "avete lavorato. Ora vorreste riposare anziché continuare a lavorare? E allora morite "cani rognosi" che non avete voluto ringraziare Dio, ma solo voi stessi".
Scrive Esiodo:
Facilmente Zeus, se vuole, può dare agio infinito a più figli; maggiore è il lavoro di molti, maggiore il profitto.
In Esiodo c'è un futuro che continua e il lavoro produce benessere anche per il futuro che viene: nel cristianesimo non c'è futuro. Il cristiano pensa a sé stesso some l'alfa e l'omega; nulla dopo di lui.
Che piaccia o meno al Dio dei cristiani, la vita continua il suo eterno corso ed Esiodo indica come il presente sia in continua trasformazione e l'uomo, agendo in esso, è compartecipe e attore di questa trasformazione: non il Dio dei cristiani!
Se non commentiamo i principi etico-morali-sociali degli antichi confrontandoli con i principi etico-morali-sociali di oggi, non cogliamo l'orrore imposto da ebrei e cristiani alle società civili e permettiamo ad ebrei e cristiani di offendere gli antichi attraverso la miseria e l'orrore del loro pensiero etico-morale-sociale.
Gli Antichi non servono per fare archeologia del pensiero sociale, ma per capire le incongruenze di un presente che stride fra morale imposta e necessità degli uomini.
Tutti i testi del mese di luglio 2025 in un'unica pagina
Indice pagine mensili di cronache Pagane
Torna agli argomenti del sito Religione Pagana
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
Membro fondatore
della Federazione Pagana
Piaz.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
Tel. 3277862784
e-mail: claudiosimeoni@libero.it
Iside con bambino - Museo di Napoli prestata a Torino!
Questo sito non usa cookie. Questo sito non traccia i visitatori. Questo sito non chiede dati personali. Questo sito non tratta denaro.