
Rimpiangiamo: per non aver pensato quello che avremmo dovuto pensare quando potevamo pensarlo;
per non aver detto quello che avremmo potuto dire quando potevamo dirlo;
per non aver fatto quello che avremmo dovuto fare quando potevamo farlo
Luglio 2025: la filosofia metafisica della Religione Pagana.
29 luglio 2025

Se il concetto di Parmenide di "ciò che E' e ciò che non E', "non si riferisce all'Essere (del che dubito per la relazione che aveva con l'Uno dei Pitagorici), ma si riferisce alla rappresentazione dell'oggetto. altro non sarebbe che un diverso modo di chiamare la "negazione della negazione".
Scrive Parmenide nel Poema sulla Natura:
Ecco che ora ti dico, e tu fa' tesoro del detto, quelle che sono le sole due vie di ricerca pensabili: l'una com'"è", e come impossibile sia che "non sia", di persuasione è la strada, ché a verità s'accompagna, l'altra come "non è", come sia necessario "non sia", che ti dichiaro sentiero del tutto estraneo al sapere: mai capiresti ciò che "non è", è cosa impossibile, né definirlo potresti...
Se tutto questo viene interpretato secondo un cammino, una via, "ciò che è" è ciò che ha cessato di essere per com'era.
Il "non sia" è il non era che non permane, è negato, in quanto ciò che è non è più ciò che era.
Il passaggio fra ciò che era in ciò che è; porta il ciò che è in ciò che era per trasformarsi in ciò che è diverso dal ciò che era.
Questo processo di trasformazione che nega ogni presene nel ciò che è per generare continuamente nuovi presenti della rappresentazione di ogni Essere della Natura, costituisce il cammino.
Non puoi capire ciò che è stato, che ora non è, perché la mente che indaga ciò che è stato non è la mente di quando è stato, ma è la mente di ciò che è che comprende il momento della propria rappresentazione presente e non il processo attraverso il quale la rappresentazione presente è divenuta.
Questo, ovviamente, è un mio ragionamento che, probabilmente, ha poco a che vedere col ragionamento di Parmenide in quanto, secondo il traduttore che uso, Parmenide più avanti scrive:
Allora di via resta soltanto una parola, che "è". Su questa ci sono segnali molteplici, che senza nascita è l'Essere e senza morte, tutto intero, unigenito, immobile, ed incompiuto mai è stato o sarà, perch'è tutt'insieme adesso, uno, continuo. Quale sua nascita andrai ricercando? Come, da dove fruttato? Non lascerò che tu dica o pensi dal nulla, perché né dire si può né pensare ch'esso non sia. Che bisogno l'avrebbe mai spinto a nascere dopo piuttosto che prima, se fosse nato dal nulla?
Essendo Parmenide un seguace dei pitagorici dove il numero uno rappresenta l'Essere, come soggetto al di sopra e al di fuori del presente, viene mantenuta tutta l'ambiguità dei frammenti.
Questo continuo riferimento all'Essere, inteso come presenza al di fuori della realtà quotidiana vissuta, ha indotto molti filosofi a considerarlo come il primo filosofo ontologico.
Si potrebbe dire che, per i frammenti rimasti relativi al pensiero di Parmenide, uno è com'è e l'altro come potrebbe essere e che, comunque, non è anche se qualcuno vuole che sia.
Agli ontologici, che proclamano la verità dell'Essere, di Dio, va fatta la domanda che Parmenide mette in bocca a Persefone: "Che bisogno l'avrebbe mai spinto a nascere dopo piuttosto che prima, se fosse nato dal nulla?". Ma ancora l'altra domanda che, taciuta, a mio avviso dimostra la malvagità degli ontologici: "Che bisogno l'avrebbe mai spinto a nascere il mondo dopo piuttosto che prima, se fosse "senza nascita è l'Essere e senza morte"?"
In ultima istanza, chi interpreta e analizza costruisce modelli di pensiero con cui interpretare la realtà in cui vive perché ciò che è stato non è, e ciò che è non è mai stato, anche se da quello si è generato ciò che è.
Nota: Le citazioni di Parmenide sono tratte da: Parmenide, Poema sulla Natura, traduzione di Giovanni Cerri, Editore BUR, maggio 2000, da pag. 149 e 151 - 152
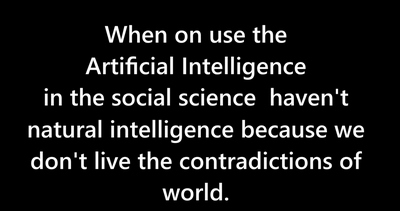
29 luglio 2025
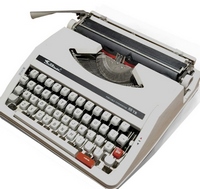
Quando un individuo scrive un testo di, dico come esempio, filosofia metafisica, per quanto grande sia la sua preparazione, scriverà sempre un testo partendo da ciò che lui sa (la verità che ha raggiunto) e ciò che crede che sia (le proprie convinzioni).
Se questa persona continua con i suoi studi, potrebbe scoprire altre cose, di quel medesimo argomento, che non sapeva o che interpretava male.
Davanti a questo ci sono due atteggiamenti diversi.
Il primo atteggiamento è quello ideologicamente cristiano: l'individuo revisiona il testo che ha scritto, cancella il vecchio e presenta il nuovo. Il suo testo deve avere la caratteristica di "verità", non può trasmettere qualche cosa di non vero perché, altrimenti, l'ambiente cristiano lo qualifica come falso o menzognero.
Il secondo atteggiamento è quello ideologicamente pagano: l'individuo riscrive un nuovo testo, non cancella quello precedente e sottolinea il passaggio fra il vecchio modo di vedere la questione e il nuovo modo di affrontare la questione.
Mentre nell'ideologia cristiana si racconta la verità in essere comunque percepita e vissuta dal soggetto; nell'ideologia pagana si racconta della trasformazione, di quel processo di ricerca del vero, che non squalifica ciò che si era, ma sottolinea la volontà di ricerca e di trasformazione.
29 luglio 2025

C'è sempre stata la contrapposizione fra il pensiero religioso degli Dèi e la rappresentazione poetica e le storie che si volevano raccontare sugli Dèi che, per questo uso, venivano descritti in termini antropomorfi.
I poeti, Omero ed Esiodo, Orfeo e Museo, non pensavano agli Dèi come Esseri Antropomorfici, ma rappresentavano gli Dèi in termini antropomorfici per raccontare le storie e trasmettere modelli esistenziali.
Il fatto che molte persone pensassero agli Dèi in forma antropomorfica, è una peculiarità umana di ridurre tutto alla forma umana, questo non significa che i poeti pensassero gli Dèi in forma Antropomorfica.
Questa riflessione di Ammonio di Alessandria del VI secolo d.c. che riporto presa da "I sentieri della sapienza da Velia ad Agrigento, da Parmenide a Empedocle" di Laura Gemelli Marciano, Editore Valla, 2024, p. 317 mi sembra abbastanza chiarificatrice.
Ammonio di Alessandria visse ad Alessandria d'Egitto nel VI secolo d.C., neoplatonico che difese la teoria delle idee di Platone contro le riflessioni di Aristotele. Era il periodo in cui gli ultimi neoplatonici tentavano di reinterpretare il platonismo e Aristotele affinché affrontasse il cristianesimo.
155. Ammonio, Commento a Sull'interpretazione di Aristotele, p. 249, 1-11 Busse (DK 31 B 134)
Per questo, anche il sapiente di Agrigento [Empedocle], stigmatizzando i miti narrati dai poeti sull'antropomorfismo degli dèi, ha introdotto in primo luogo versi su Apollo, sul quale verteva principalmente il suo discorso, ma esprimendosi senz'altro allo stesso modo anche sul divino in generale:
infatti non è provvisto di testa umana sulle membra,
non gli spuntano dal dorso due rami [braccia],
non ha piedi, non veloci ginocchia, non genitali villosi,
ma è solo una phren sacra e ineffabile
che con rapide cure si slancia giù attraverso tutto il cosmo.
[Phrén = mente, ciò che si proietta nella comunicazione e ciò che si percepisce dell'altro a prescindere delle modalità e degli strumenti con cui avviene la comunicazione.]
In questa condizione, la lotta non era contro i poeti, ma contro chi riteneva reale la forma con cui i poeti raccontavano il divino. Solo i poeti erano in grado di trasmettere il divino suscitando emozioni.
Tutti i testi del mese di luglio 2025 in un'unica pagina
Indice pagine mensili di cronache Pagane
Torna agli argomenti del sito Religione Pagana
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
Membro fondatore
della Federazione Pagana
Piaz.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
Tel. 3277862784
e-mail: claudiosimeoni@libero.it
Iside con bambino - Museo di Napoli prestata a Torino!
Questo sito non usa cookie. Questo sito non traccia i visitatori. Questo sito non chiede dati personali. Questo sito non tratta denaro.